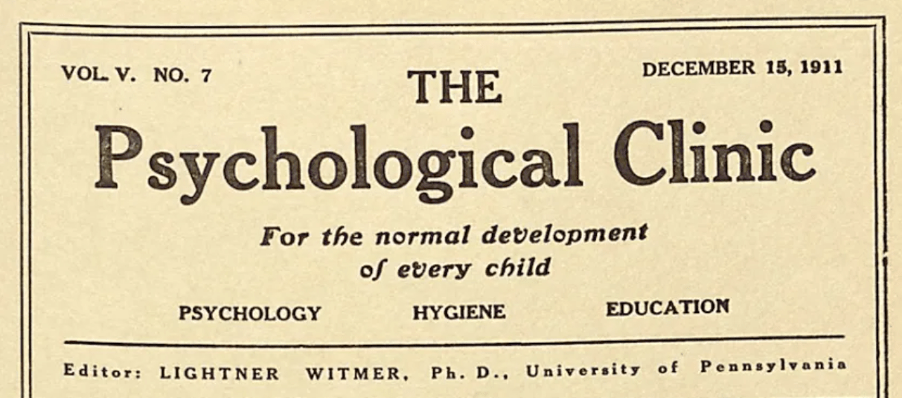Seconda parte dell’articolo Sul Senso della clinica in medicina.
Nel primo decennio del 1900 la psicologia prese in prestito il termine clinica per riorientarsi in quanto professione – non solo scienza – psicologica, ritrovandosi nel corso del tempo all’interno di una cornice comprensiva e di intervento prettamente individualistica, incentrata spesso sulle sole funzioni di diagnosi e cura intese limitatamente in termini (bio)medico-clinici. La psicologia clinica oramai, sulla base dei riferimenti che potrebbero essere utilizzati per indicare il momento della sua costituzione, si ritrova ad avere circa un secolo di storia. Generalmente si ritiene che questa si sia costituita, intorno all’ultimo decennio del 1800 e ai primi decenni del 1900, a partire dall’incontro della tradizione psicometrica e della tradizione dinamico-psicoanalitica (Korchin, 1976. In Grasso, M., 2000; Reuchlin, 1971. In Lombardo, G. P., & Foschi, R., 1997): l’incontro di queste tradizioni culturali ha permesso di riconoscere nella psicologia clinica sia il fine di comprendere e spiegare il funzionamento psichico dell’individuo sia il poter intervenire in termini terapeutici su quest’ultimo qualora presenti determinate problematiche di carattere mentale e/o comportamentale. Si tratta quindi di una duplice dimensione operativa che consente di incorporare all’interno della psicologia clinica tanto l’attenzione per la persona sana quanto l’attenzione per la persona malata, tanto l’importanza per la valutazione psicologica (attraverso, ma non soltanto, test e scale) quanto per l’intervento; questo ha comportato col tempo un’assimilazione tout court delle conoscenze e competenze della professione psicologico-clinica alle pratiche mediche di diagnosie terapia, fino ad arrivare ad una sostanziale identificazione di quest’ultima con l’intervento psicoterapeutico – e della stessa psicologia con clinica; identificazione aproblematicamente rinforzata da media, senso comune e professionisti stessi che, tuttavia, si basa su una concezione ristretta e limitata della psicologia clinica (e della clinica).
L’accostamento del termine “clinica” a “psicologia” e una prima definizione di questa nuova professione si deve a Lightner Witmer (1867-1956) e John E. W. Wallin (1876-1969): questi tentarono di determinarne le competenze, precisandone scopi e contenuti di intervento, con l’intento di differenziarla ad extra da altri domini medici e ad intra da altri domini psicologici, per conferirle una sua autonomia, un proprio spazio tra il predominio crescente delle altre scienze. Witmer, pur riconoscendo i rischi impliciti nel riferirsi alla psicologia con il termine “clinica”, aveva sin dal principio sostenuto che “while the term “clinical” has been borrowed from medicine, clinical psychology is not a medical psychology. I have borrowed the word “clinical” from medicine, because it is the best term I can find to indicate the character of the method which I deem necessary for this work” (Witmer, L., 1907: p. 8) sottolineando come questo indichi un metodo, e non uno spazio: un metodo che avrebbe permesso alla psicologia di distanziarsi tanto dall’inconsistenza scientifica della filosofia quanto dai risultati di laboratorio acriticamente applicati ai bambini all’interno del contesto scolastico, per fondare la propria professione su un’osservazione sistematica delle problematiche presentate per intervenire criticamente – e secondo criteri scientifici – nella loro risoluzione all’interno di strutture specificatamente dedicate (psychological clinics). In questo primissimo periodo di costituzione della psicologia clinica, l’interesse era quindi prioritariamente rivolto allo studio e al trattamento di bambini in età scolare caratterizzati da moral defects, da “retardation or physical defects interfering with school progress” (ivi: p. 5). Queste le parole di John E. W. Wallin: “Clinical psychology is not synonymous with medical psychology. Clinical means literally bedside and was applied originally to the first-hand bedside method of studying the individual patient. In psychology it designates the method of determining the mental status of an individual child by first-hand observation, testing and experiment. It may be used in the study of normal as well as of abnormal mentality. We may suggest the use of the words psycho-clinical and medico-clinical to designate, respectively, psychological and medical examination by the clinical method” (In Ceccarelli, G., 2013: p. 303). Questi autori volevano quindi rivendicare – nonostante non siano sempre riusciti ad essere chiari ed esaustivi – “il diritto all’esistenza di una simile declinazione applicativa della psicologia, adducendo ragioni epistemologiche, teoriche, operative e formative […] cercando di precisare cos’è e cosa non è la psicologia clinica, quali problemi affronta, cosa fa e come deve essere formato lo psicologo clinico, di quali soggetti deve occuparsi, facendo riferimento pure al trattamento e pensandolo di diversa natura: educativo, psico-educativo, medico, sociologico, sociale, morale, con esiti evidentemente non sempre chiarificanti” (Ceccarelli, G., 2013: p. 308).
Per questo non si riesce alla fine ad arrivare a una definizione precisa, propria di questo metodo «psicoclinico», delle differenze con la medicina e della stessa psicologia clinica. L’intenzione di creare una «clinica» propriamente psicologica era quindi, forse, ingenua e prematura per il tempo; ingenua in quanto erano state sottovalutate le ramificazioni di questa scelta e prematura in quanto ancora era assente una tradizione scientifico-pratica a sostenerla: basti pensare che, nel 1935 – a quasi quarant’anni dalla fondazione della prima psychological clinic – si trovano ancora articoli come il Report of Committee of Clinical Section of American Psychological Association, dedicato, nella sua prima parte, all’ennesimo tentativo di definizione della psicologia cosiddetta clinica (ivi).
Nel contesto italiano si deve attendere, per una sua prima sistematizzazione, quasi 60 anni dalla costituzione della psicologia clinica negli Stati Uniti: il 28-29 settembre del 1952, Agostino Gemelli organizza il primo Simposio internazionale di psicologia clinica[1], il cui fine ultimo consisteva nel “chiarire il concetto di psicologia clinica; determinare i limiti dell’azione dello psicologo clinico, esaminare chi è chiamato a esercitare questa nuova branca della psicologia, determinare il valore dei metodi che la psicologia clinica impiega” (ibidem), soprattutto in contrapposizione a discipline affini, quali medicina e psichiatria. Il contesto italiano si caratterizzava per un’ancora presente spaccatura tra la psicologica scientifica e la psicologia clinica, tra ricerca, teoria e prassi, tra formazione e professione. La scienza psicologica era, sin dal principio, interessata al solo dover-essere una scienza naturalisticamente impostata al pari della medicina: lo studente era formato essenzialmente nella psicologia sperimentale, nella ricerca controllata in laboratorio tesa alla quantificazione e al possesso del positum psichico. Contemporaneamente, la professione psicologica esisteva soltanto in quanto psicologia “pre-clinica”, applicata, arida psicotecnica, scevra da influenze della ricerca psicologica internazionale e strettamente ancorata ad un criterio utilitaristico rivolto al contesto sociale[2]; oppure in quanto psicologia medico-psichiatrica, asservita al potere medico, priva di una proprio specifico pro-getto scientifico-culturale e duplicato ad armi spuntate della psichiatria (per usare un’espressione di R. Vitelli, 2012: p. 216). Nel suo tentare di crearsi un proprio spazio e ottenere un riconoscimento sociale, culturale in quanto scienza e professione, la psicologia clinica non ha potuto (o saputo) fare altro se non lentamente adattarsi a un pro-getto medico-sanitario non pensato, non proprio, fatto proprio.
La condizione in cui versa attualmente la psicologia clinica sembra quindi sia sorta all’interno di un lento processo caratterizzato in principio dall’accostamento del termine “clinica” alla psicologia – e quindi dall’adesione, spesso inconsapevole, ad un modello medico-clinico di valutazione e intervento. Problematici sono stati successivamente il rifiuto della riflessione filosofica, la ricerca di un proprio essere scienza in un’impostazione naturalistica, apersonale e statica e dalla spaccatura che questa ha creato con la pratica clinica o ancora l’assenza di una sistematica tradizione culturale scientifico-psicologica di supporto che ha portato la psicologia clinica a voler “fare la stessa cosa che fa lo psichiatra” (Palmonari, A., & Zani, B., 1981. In Lombardo, G. P., 1994: p. 149). E questo significa scontrarsi (raramente incontrarsi o confrontarsi) con la professione medico-psichiatrica, spesso sovrapponendosi a quest’ultima (opportunamente o meno, in dipendenza dei casi) – fino ad identificare il proprio poter-essere esclusivamente in termini diagnostici e (psico)terapeutici, competenze queste esercitate in quanto libero professionista e basate su un paradigma di tipo tradizionalmente medico-individualistico e sul solo, ristretto rapporto paziente-terapeuta.
Il predominio culturale di una prospettiva riduzionista, scientista, biologistica e medicalizzante derivata dall’importanza assunta successivamente dalle neuroscienze, dalla neurofarmacologia e dalla genetica del comportamento (Pagano, P., 2009), ha intaccato l’essenza stessa della psicologia clinica, il rapporto clinico, l’inclinarsi: resta alla base un pensiero naturalistico-biomedico attraverso cui si rischia di interessarsi di un isolato corpo (o cervello) sine animo e di orientare la clinica non tanto verso la persona quanto piuttosto verso il solo meccanismo mentale o sintomo circoscritto da dover rimuovere per “curare” il comportamento o il pensiero anormale del malato. Lo psicologo clinico diviene quindi – pur con le dovute eccezioni – inefficace nel proporsi come studioso della persona e dell’(inter)soggettivo e come professionista rivolto primariamente all’ascolto e alla relazione, e non all’arido tecnicismo di derivazione biomedica. Diversi studiosi – tra cui G. Albee (2000) – hanno evidenziato come un’accettazione acritica dell’impostazione medica da parte della psicologia sia stata “un errore fatale che da sempre ha distorto e danneggiato lo sviluppo della Psicologia Clinica” (ivi), condotta a riporre la propria attenzione quasi esclusivamente sulla psicopatologia individuale e alle funzioni di diagnosi e cura di stampo prettamente medico-clinico, limitando il proprio potenziale scientifico-professionale e creando controversie nel rapporto con la professione medico-psichiatrica.
Questo conduce a (ri)domandarsi quale clinica sia propria, specifica della psicologia clinica.
Se la storia della medicina permette di comprendere – ma non accettare – un’attuale clinica intesa ristrettamente in termini di cura, questa clinica non deve essere riferita alla psicologia, in cui essenziale, curativo risulta primariamente l’incontro terapeutico, la relazione, il prendersi cura. Il metodo clinico – sulla scia di L. Pinkus (1975) – si riferisce soprattutto all’utilizzo del rapporto interpersonale come strumento di conoscenza del reale; ad una metodologia di studio basata sull’osservazione diretta e sistematica, nei suoi momenti di analisi e di sintesi, tanto di un solo individuo quanto di un gruppo, implicando un lavoro sul campo e l’utilizzazione di una ‘dimensione storica’; ad un sistema didattico basato sull’esperienza diretta del reale piuttosto che sull’uso di modelli artificiali. Tutte queste dimensioni – del rapporto interpersonale, dell’osservazione sistematica e dell’esperienza diretta – possono risultare e risultano caratteristiche per un orientamento prettamente psicologico, e per una psicologia clinica distinta dalla medicina e da una clinica di esclusiva derivazione (bio)medica. Il significato originario di «clinico», il rimando al senso dell’antica kline, permane idealmente, illusoriamente in psicologia, mentre si differenzia tutt’ora tra questa e la medicina: numerosi problemi sono derivati proprio da queste differenti accezioni della clinica – e da un’assenza di riflessione critica sull’impatto metodologico di questa confusione terminologica (Imbasciati, A., 2008: 135).
Prendiamo in considerazione la diagnosi. La diagnostica medica si caratterizza per una stretta interdipendenza tra la conoscenza di un «normale» e della controparte «patologica». Turchi e Sposini (2016: p. 28) ricordano come all’anatomia corrisponda necessariamente un’anatomia-patologica, alla fisiologia una fisio-patologia e alla genetica una patologia-genetica: partendo dalla dimensione biologica «normale» e «sana» “si osserva un rapporto di opposizione lineare con dei rispettivi campi di patologia”. Lo sguardo medico si orienta quindi costantemente nell’incontro e nel confronto tra questi domini contrapposti, per riuscire a individuare, attraverso una diagnostica generalmente tanto affidabile quanto valida, una determinata malattia – e coerentemente delineare il percorso terapeutico necessario a risanare la persona sofferente. “In un certo senso – scrive G. Di Petta (2022) – in chi pratica queste discipline o altre simili, si innesca un circuito di retroazione immediato tra la prassi e i risultati della prassi, i quali, sottoposti a verifica, finiscono per influenzare la ripartenza corretta del circuito. I dati”. Sostenendosi su un’inconsistente distinzione tra normale e anormale – ma acriticamente considerata reale, evidente, inequivocabile – lo sguardo psicologico (come quello psichiatrico) si trova al contrario a non avere nulla su cui potersi sostenere e attraverso cui potersi orientare. “Quali sono le nostre “datità”? Quali sono i vincoli di senso che sussistono tra di esse? I legami, le connessioni, i rimandi significativi? Quanto esprime un sorriso, un pianto, un silenzio, un sospiro? Cosa sottolineano? La diversa qualità del silenzio. Certe tensioni muscolari, certi atteggiamenti, certi sguardi?” (ivi).
Pensiamo proprio allo sguardo. Un problema condiviso del processo diagnostico tanto medico quanto psicologico sta nel predominio dello sguardo sull’ascolto, soprattutto in medicina in cui la tecnica lo ha reso superfluo: il medico spesso non ascolta, per curare non serve. Ma la clinica – se vuole prendersi cura e non solo curare – deve anche saper ascoltare, sentire. E l’ascolto – come scrive E. Priani (2012) – “nasce innocente”, corrisponde all’orecchiare o porgere l’orecchio indicando la sua costitutiva naturalezza in quanto direttamente connesso al proprio corpo e al suo in-tendere, inclinarsi verso l’altro, trascendendo i propri confini carnali: ascoltare significa porgere attentamente l’orecchio, stare a udire con attenzione e tendere l’orecchio in silenzio – un silenzio che permette l’ascolto, senza cui l’ascolto stesso non sarebbe tale (ivi) e dimenticato dalla diagnostica attuale che parla, spesso inconsapevolmente oltre quello che potrebbe o dovrebbe dire, e raramente ascolta (o si ascolta). Ascoltare quindi, ma con tutto il corpo: qui, l’ascolto diventa sentire. Esiste tuttavia anche un ascolto rischioso, iatrogeno, come quello che si limita alla ‘domanda del paziente’ – in una riduttiva logica binaria domanda/risposta – senza ascoltare la persona nel suo essere umana, nel contatto reciproco e nel sentire co-costruito che scaturisce dall’incontro; o ancora quello che ascolta solo per ricondurre a qualcosa di conosciuto, per incastrare la sofferenza nella psicobiografia del paziente e ricondurla successivamente a prototipi classificatori descrittivo-narrativi che annientano in psicologismi il suo essere persona – alla pari dei desertici criteri del DSM. Spesso – soprattutto in medicina – si distanzia la persona e qualsiasi intuizione questa possa avere sulla propria condizione di sofferenza: come scrive Imbasciati (2008: p. 15), sopravviene “un certo fastidio se il malato emette qualche messaggio che sembra non rientrare nel quadro oggetto d’indagine: sembra che l’evento ci distragga dalla nostra presunta “obiettività”.
Per questo sia nella clinica di derivazione (bio)medica sia nella clinica di una psicologia medicalizzata, nonostante le differenze, l’impostazione alla base resta ormai la stessa (individualistica, patofilica e transitiva), e l’ascolto, perduta nei secoli la propria innocenza, diventa “finalistico e antropomorfico, a misura umana e del tempo umano, strumentale” (Priani, E., 2012). Si deve recuperare quell’archetipo di ascolto che Priani (2012) definisce ascolto delle origini[3] e la diagnosi deve tornare ad essere una dia–gnosis, un conoscere attraverso, un attraversarsi per incontrarsi. E anche questo implica un tendere verso, un inclinarsi.
[1] Problemi relativi alla psicologia clinica erano stati introdotti in Italia poco tempo prima, durante il IX Convegno degli psicologi italiani (1951) a Roma, attraverso le relazioni di Gozzano e Canziani.
[2] Il termine ‘psicotecnica’, introdotto da William Stern (1871-1938) – e da Guido Della Valle (1884-1962) in Italia – si riferiva all’applicazione pratica della psicologia finalizzata alla risoluzione concreta e socialmente utile di problematiche riscontrate in contesti educativi e lavorativi. Ma come scriveva H. J. Urban nel 1952 “sotto l’influsso delle scienze naturali la psicologia diventa psicotecnica e sbarra l’accesso ad una antropologia totalitaria. Soltanto un «uomo macchina» avrebbe bisogno di uno psicotecnico” (In AA. VV., 1952: p. 57).
[3] “Nell’ascolto delle origini riteniamo di riconoscere un archetipo di ascolto mai più vissuto nelle epoche successive: l’uomo che precede l’avvento e la definitiva interiorizzazione della parola scritta, abita con i suoi simili uno stesso universo simbolico ed antropologico nel quale i significati, i valori, i vissuti, i riferimenti di senso, sono immediatamente condivisi; in questo stadio della civiltà che precede la nascita della soggettività e della coscienza, una sorta di empatia cosmica governa le vicende degli uomini, degli dei, del mondo, dove i confini tra queste tre dimensioni sono ancora mobili e fluttuanti. La comunione e la reciproca coappartenenza ad un medesimo mondo fanno si che si crei unitarietà e pienezza di senso tra chi ascolta, chi viene ascoltato e ciò che viene ascoltato; in questa fase aurorale della nostra civiltà, l’uomo abita ancora il mondo e lo abita in maniera radicale in quanto sua parte, senza le successive mediazioni date dalle descrizioni razionali del mondo o da sue secondarie modellizzazioni. Sarà proprio attraverso queste ultime che inizierà invece quel progressivo processo di selezione-riduzione e graduale contrazione dei processi di ascolto in cui il simile non ascolterà più il simile, ma l’uomo ascolterà l’altro uomo nelle forme e nei modi dati dal costrutto logico-razionale e storico sociale che lo istituiscono e che lo sovradeterminano. Tali costrutti porteranno in sé un proprio modello antropologico, saranno sottesi da una specifica e storicamente determinata idea di uomo” (Priani, E., 2012).
BIBLIOGRAFIA
Ceccarelli, G. (2013). Questioni fondative agli esordi della psicologia clinica. Physis, Rivista Internazionale di Storia della Scienza, 49(1-2), 293-315.
Di Petta, G. (2022). Lettera di Gilberto Di Petta ai soci. Mitdasein. Rivista dell’Associazione Italiana Psicologia Fenomenologica(Aipf). https://associazionepsicologiafenomenologica.it/lettera-di-gilberto-di-petta-ai-soci/
Grasso, M. (2000). Psicologia Clinica. Treccani, Enciclopedia Italiana Online. https://www.treccani.it/enciclopedia/psicologia-clinica_%28Enciclopedia-Italiana%29/
Imbasciati, A. (2008). La mente medica: che significa “umanizzazione” della medicina? Milano, Italia: Springer-Verlag Italia.
Lombardo, G. P. (A cura di) (1994). Storia e modelli della formazione dello psicologo. Le teorie dell’intervento. Milano, Italia: Franco Angeli Editore.
Lombardo, G. P., & Foschi, R. (1997). La psicologia italiana e il Novecento. Le prospettive emergenti nella prima metà del secolo. Milano, Italia: Franco Angeli Editore.
Pagano, P. (2009). Il modello medico in psicologia clinica. Rivista di Psicologia Clinica, (2).
Priani, E. (2012). Auscultum. Psychiatry On Line Italia. Disponibile 16 Marzo, 2021, da http://www.psychiatryonline.it/node/2134
Turchi, G. P., & Sposini, F. M. (2016). On the normative possibilities in psychology and psychiatry. Rivista di Psicologia Clinica, (2), 24-40.
Vitelli, R. (2012). Formazione, Ricerca e Processi di Cura in Psicologia Clinica: alcune note a margine del libro di Renzo Carli e Rosa Maria Paniccia “La cultura dei servizi di salute mentale in Italia. Dai malati psichiatrici alla nuova utenza: l’evoluzione della domanda di aiuto e delle dinamiche di rapporto”. Rivista di Psicologia Clinica, (2), 212-223.
Witmer, L. (1907). Clinical psychology. The Psychological Clinic, 1(1), 1-9.